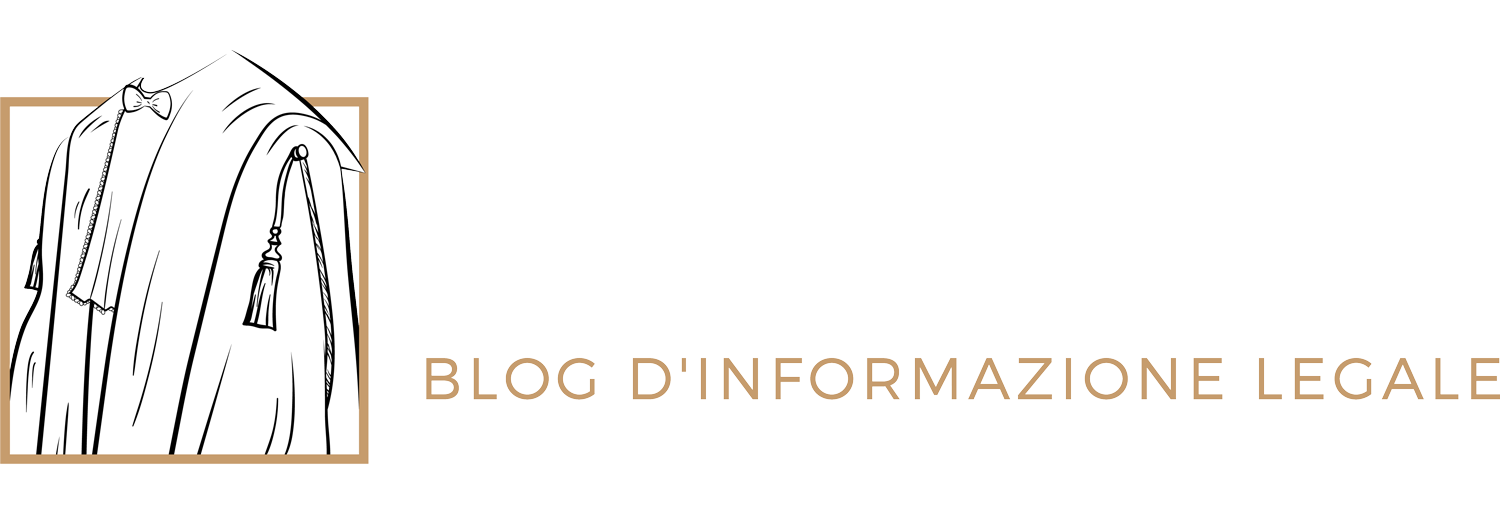La Corte dei Conti smentisce la narrazione politica. Squilibrio contabile, benefici sovrastimati e oneri a carico delle generazioni future.
Di Enrico Pellegrini
Il Superbonus 110% è stato presentato, sin dalla sua introduzione, come un volano per l’economia nazionale, un’occasione irripetibile di rilancio del comparto edilizio, di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e di promozione della transizione ecologica. Ma la retorica politica, oggi, si infrange contro una realtà documentata: quella esposta dalla Corte dei conti, che in una recente relazione ufficiale ha fornito una valutazione impietosa, e per certi versi definitiva, sugli effetti della misura.
I numeri sono allarmanti. Secondo i dati consolidati e aggiornati al 31 maggio 2025, elaborati da ENEA e trasmessi alla magistratura contabile, il costo per lo Stato dei soli lavori già conclusi supera i 126 miliardi di euro, con una proiezione finale che raggiunge i 150 miliardi. Una voragine nei conti pubblici, destinata ad appesantire in maniera strutturale il debito nazionale, che ha già superato il 135% del PIL. Ma ciò che più preoccupa è la qualità della spesa: interventi massicci, spesso non prioritari, che hanno avvantaggiato principalmente proprietari di immobili di pregio, residenze unifamiliari e persino edifici storici accatastati in categoria A/9.
A mancare, sin dall’origine, è stata una cornice di sostenibilità giuridico-finanziaria. Nessun limite ISEE, nessun tetto di spesa, nessun criterio selettivo basato sulla reale necessità degli interventi o sulla loro efficienza energetica. Un sistema che ha incentivato l’accesso indiscriminato agli incentivi, spesso senza un’adeguata progettazione o controllo preventivo, generando distorsioni di mercato, aumento incontrollato dei costi delle materie prime e congestione operativa nel settore edilizio.
Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra il 2020 e il 2023 la spesa complessiva per i bonus edilizi ha toccato quota 186 miliardi di euro, contro 116 miliardi di investimenti effettivi, con una “spesa morta” stimata in 70 miliardi. Bankitalia e l’Ufficio parlamentare di bilancio parlano rispettivamente di inefficienze pari al 27% e al 33%, mentre analisi indipendenti stimano che un euro su 2,5 sia stato assorbito senza reali benefici sistemici. La Cgia di Mestre, dal canto suo, ha calcolato che l’impatto ambientale positivo sarà riscontrabile solo dopo circa 40 anni. Nel frattempo, si rileva un tasso d’infortuni in cantiere in netta crescita e un numero significativo di imprese bloccate dal caos normativo sulla cessione dei crediti.
Il giudizio della Corte dei conti è dunque netto: una misura nata senza visione strategica, priva di presidi giuridici idonei a prevenire abusi, e incapace di generare una crescita duratura. La magistratura contabile ha sottolineato non solo l’impatto passivo sulle finanze pubbliche, ma anche il rischio di lesione del principio di equità fiscale, dal momento che le agevolazioni hanno beneficiato in misura prevalente soggetti già abbienti, lasciando fuori le fasce deboli. Una redistribuzione alla rovescia, in violazione dell’art. 53 Cost.
La vicenda del Superbonus interpella dunque non solo l’efficienza amministrativa, ma la coerenza dell’azione pubblica con i principi costituzionali. Una riflessione giuridica seria non può ignorare la sproporzione tra costi e benefici, l’assenza di controlli preventivi, la mancata introduzione di condizioni soggettive e oggettive per l’accesso al beneficio, e l’erronea presunzione che la spesa pubblica in sé sia sempre generatrice di crescita.
Il tempo della propaganda è finito. Oggi resta il tempo della responsabilità. E della contabilità pubblica, che non è mai neutra. Il Superbonus è stato un caso emblematico di come una misura emergenziale, se non costruita su solide basi giuridiche e tecniche, possa degenerare in un fallimento strutturale. Oggi la magistratura contabile ne certifica il fallimento definitivo.