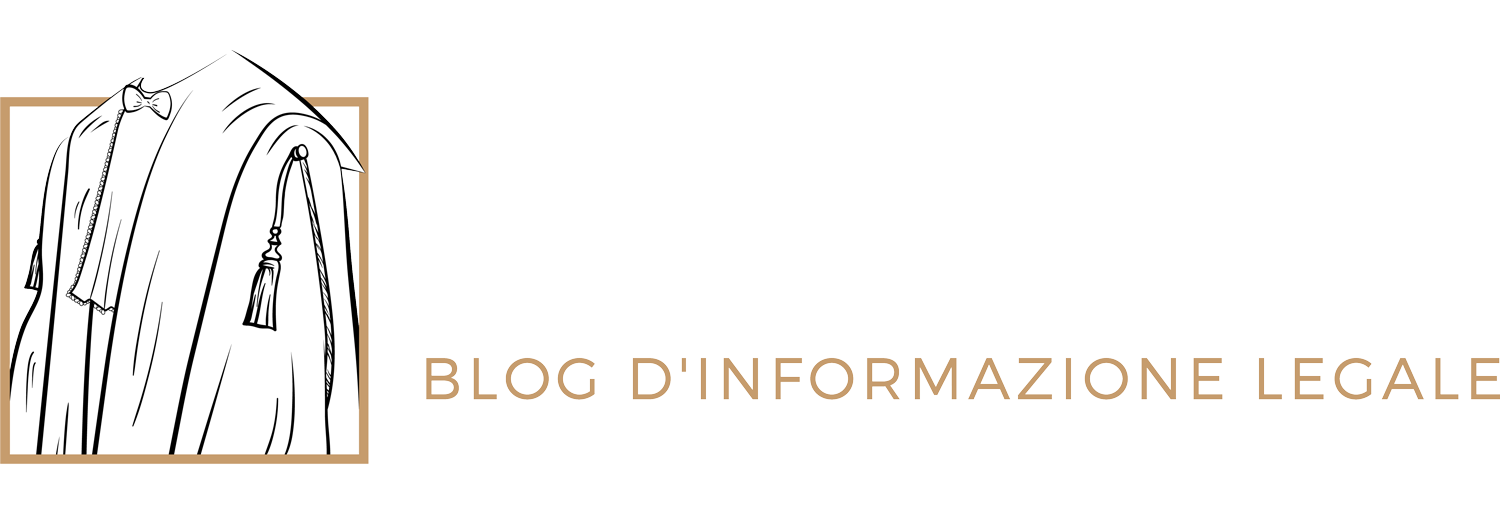Dal “Salva-Casa” alla delega in discussione alla Camera, che cosa è già legge e che cosa potrebbe cambiare nel nuovo impianto del D.P.R. 380/2001
Di Enrico Pellegrini:
Il sistema edilizio italiano sta vivendo un passaggio che può definirsi epocale. Dopo vent’anni di stratificazioni normative sul D.P.R. 380 del 2001, il cosiddetto Testo Unico Edilizia, il legislatore ha aperto un doppio fronte di intervento. Da un lato, con il decreto-legge 69 del 2024, convertito nella legge 105 dello stesso anno, si è già intervenuti su alcuni degli istituti più delicati, introducendo modifiche immediatamente operative. Dall’altro, alla Camera è incardinata la proposta di legge delega A.C. 2332, collegata alla A.C. 535, che affida al Governo il compito di riscrivere e riordinare l’intera disciplina, con l’obiettivo di adottare un nuovo Testo Unico capace di razionalizzare procedure e principi.
Il “Salva-Casa” ha inciso innanzitutto sulla nozione di stato legittimo, rendendo più lineare la sua ricostruzione. Oggi è possibile far valere non soltanto la sequenza completa di tutti i titoli edilizi rilasciati, ma anche il solo titolo più recente che abbia interessato l’intero immobile, purché l’amministrazione abbia verificato i precedenti. Concorrono a definire lo stato legittimo anche i titoli in sanatoria, le fiscalizzazioni delle opere, le tolleranze costruttive e, nei casi di immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia, anche documentazione catastale, d’archivio o fotografica. È un cambiamento che alleggerisce la prova e consente a molti immobili di vedere ricostruita la propria legittimità giuridico-amministrativa.
Altro intervento decisivo ha riguardato le tolleranze costruttive. La regola del due per cento rimane valida sempre, ma per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 le deviazioni ammissibili sono state ampliate fino al sei per cento, secondo scaglioni progressivi in base alla superficie dell’unità immobiliare. La norma riconosce una realtà diffusa, piccole difformità dimensionali non incidono sulla sostanza del progetto e non meritano di bloccare atti di trasferimento o interventi successivi.
Ancora più significativa è l’introduzione di una nuova tipologia di sanatoria, disciplinata dall’articolo 36-bis. Per difformità parziali e variazioni essenziali si apre oggi una procedura semplificata, con tempi certi e la possibilità di silenzio-assenso, quarantacinque giorni per il permesso in sanatoria e trenta per la SCIA, salvo sospensioni per vincoli paesaggistici. È una rivoluzione silenziosa che, pur mantenendo formalmente intatta la disciplina dell’articolo 36, in realtà apre un varco a regolarizzazioni più rapide e meno onerose. Non a caso la modulistica nazionale è stata aggiornata in Conferenza Unificata sia per i titoli edilizi principali sia per l’agibilità, con obbligo per Regioni e Comuni di adeguarsi entro l’autunno 2025.
Accanto a queste novità già operative, la delega parlamentare per la riforma del Testo Unico apre scenari di ben più ampio respiro. Il Servizio Studi della Camera ha chiarito che l’obiettivo è adottare un testo unico coordinato, con abrogazioni espresse delle norme superate, una disciplina transitoria uniforme e la definizione dei principi fondamentali che spettano allo Stato, in ossequio all’articolo 117 della Costituzione. Tra questi principi rientra, senza dubbio, la doppia conformità.
Ed è qui che si gioca la partita più delicata. Da sempre la doppia conformità rappresenta la barriera della sanatoria edilizia ordinaria. Non basta che l’opera sia oggi conforme agli strumenti urbanistici: occorre che lo fosse anche al tempo della realizzazione. Una regola che ha reso quasi impossibile regolarizzare gli abusi datati, alimentando un contenzioso infinito e un patrimonio edilizio spesso condannato a restare in un limbo. La Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni che si tratta di un principio fondamentale, dunque non derogabile dalle Regioni e non eliminabile con leggerezza.
Il legislatore, tuttavia, ha già avviato un processo di erosione selettiva. Con l’articolo 36-bis ha creato un binario parallelo che non richiede la doppia conformità in senso pieno, ma consente la regolarizzazione a condizioni più agili. Con le nuove tolleranze ha ampliato gli spazi di difformità non sanzionabili. Con la riscrittura dell’articolo 9-bis ha permesso di ricostruire lo stato legittimo attraverso titoli e documenti che prescindono dalla verifica puntuale di ogni fase storica. La doppia conformità resta, ma non è più l’unico modo per regolarizzare.
È per questo che la riforma delegata potrebbe segnare un punto di svolta. Nessuno si attende un’abolizione integrale del principio, che sarebbe difficilmente compatibile con l’impianto costituzionale. Ma cresce la possibilità di un ridimensionamento mirato, attraverso la tipizzazione di casi in cui la doppia conformità non sarà più richiesta. Le ipotesi circolate riguardano soprattutto gli immobili costruiti prima del 1967, quando la licenza edilizia non era ancora obbligatoria ovunque, e le difformità minori che non alterano la funzionalità o la sicurezza delle opere. In questi casi si potrebbe introdurre una sanatoria storica o semplificata, in grado di superare rigidità oggi prive di reale giustificazione.
Il tema degli immobili “ante ’67” è emblematico. La legge ponte n.765 del 1967 ha esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo della licenza edilizia, ma fino ad allora molti fabbricati erano stati realizzati legittimamente senza titolo. Oggi, in assenza di una norma chiara, la prova della loro legittimità è spesso difficoltosa, affidata a documenti catastali, fotografie d’epoca o atti d’archivio. La riforma potrebbe codificare definitivamente questo regime, stabilendo una disciplina speciale che consenta di attestare la regolarità senza dover passare attraverso il filtro della doppia conformità.
In questo scenario, la doppia conformità non scompare ma cambia volto. Da regola assoluta e inderogabile rischia di diventare un criterio di carattere generale, applicabile solo ai casi più rilevanti, mentre attorno ad essa si aprono corridoi di semplificazione per difformità marginali o per abusi storici. Non si tratterebbe di un condono, bensì di un adeguamento del sistema a una realtà edilizia stratificata e complessa.
Il futuro del Testo Unico dipenderà dall’equilibrio che il Governo saprà trovare nell’esercizio della delega. Se la riforma si limiterà a coordinare le novità già introdotte, avremo un testo più chiaro ma non sostanzialmente diverso. Se invece verranno tipizzate deroghe esplicite alla doppia conformità, potremo assistere a un vero cambio di paradigma.
Per ora, professionisti e operatori devono muoversi nel quadro tracciato dal “Salva-Casa”, ossia ricostruzione dello stato legittimo con criteri più elastici, tolleranze costruttive ampliate, sanatoria 36-bis con tempi rapidi e modulistica aggiornata. È già un contesto profondamente diverso da quello di due anni fa. Ma la vera sfida è appena iniziata, e riguarda il destino di un principio che per decenni ha rappresentato la linea di confine invalicabile tra ciò che poteva essere sanato e ciò che doveva essere demolito. La domanda che molti si pongono è se davvero la doppia conformità sia destinata a tramontare. La risposta, al momento, è che non scomparirà del tutto, ma potrebbe presto smettere di essere un dogma.