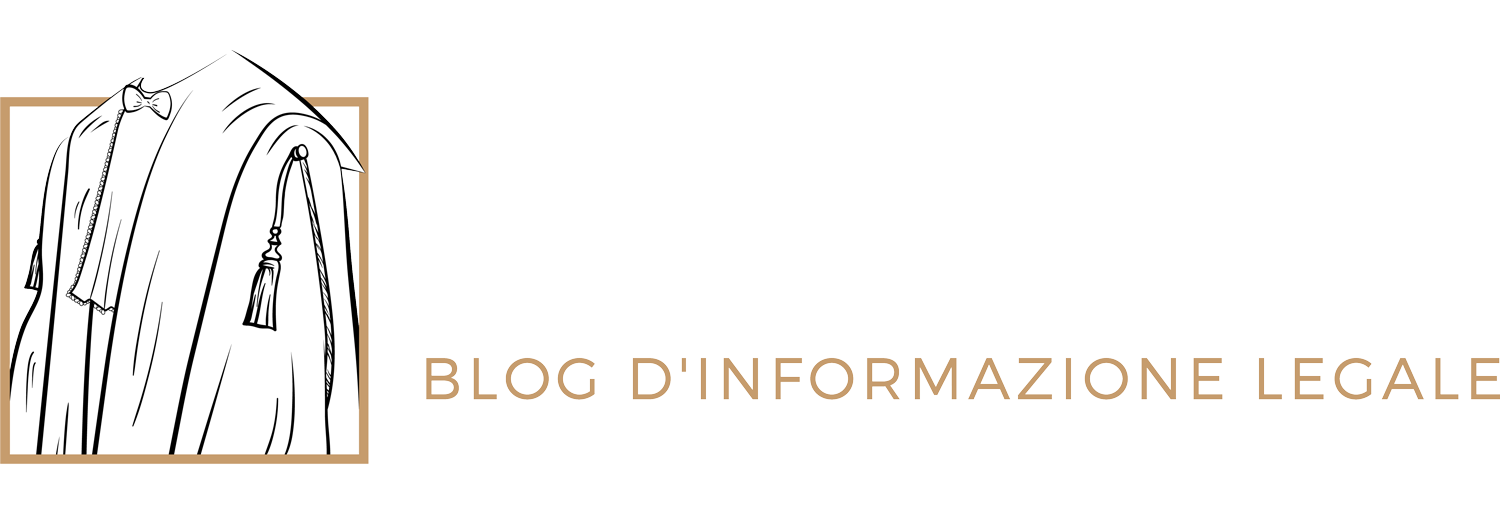Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione scelte pianificatorie, perimetri di trasformazione e metodo di formazione del piano.
di Enrico Pellegrini
C’era una volta il PRG
Prima ancora che diventi la nuova “costituzione urbanistica” di Martina Franca, il Piano Urbanistico Generale è già finito sul banco degli imputati. L’“approvando” PUG, ancora sospeso tra l’adozione e il vaglio delle osservazioni, è investito da sedici ricorsi al TAR Puglia, tutti firmati dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, che ne contestano le fondamenta di legittimità e il modo in cui il Comune ha ascoltato (o non ha ascoltato) cittadini e imprese. Per capire come si possa arrivare a mettere sotto processo un piano prima ancora che entri in vigore, bisogna però tornare indietro di quarant’anni, a quando lo strumento di governo del territorio si chiamava ancora Piano Regolatore Generale.
1984, Martina Franca, una città che cresce “per zone”
Il PRG approvato nel 1984 aveva una struttura tipica della pianificazione di quegli anni dove la città veniva divisa in “zone” omogenee, ciascuna con la propria funzione prevalente e i relativi indici.
Zone di espansione residenziale (E1, E2, E3, E4), spesso collegate all’obbligo di piani particolareggiati;
Zone agricole o agricolo–residenziali (F2-2), in realtà già all’epoca interessate da dinamiche insediative;
Zone destinate a servizi e standard (S, H1, P): verde pubblico, attrezzature collettive – scuole, verde pubblico e parcheggi;
Zone produttive e industriali (L), a ridosso delle principali direttrici infrastrutturali.
L’attuazione del PRG veniva impostata su comparti edificatori per i quali l’Amministrazione comunale aveva redatto una serie di Piani Particolareggiati, ossia aree di completamento, comparti di espansione residenziale urbani e periurbani (tra cui, ad esempio, le zone note come C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/9 “Pergolo”, “Giuliani” e “San Paolo”). In questi ambiti, almeno sulla carta, avrebbero dovuto trovare attuazione le previsioni edificatorie del piano generale in un equilibrio di realizzazione delle zone residenziali private con l’attuazione da parte del comune e delle aree a standard.
Per molti proprietari, imprese e operatori economici, quel PRG è stato per anni il parametro di riferimento:
- per programmare interventi residenziali e produttivi;
- per sopportare un carico fiscale fondato sulla qualificazione “edificabile” di terreni talvolta mai realmente pianificati in dettaglio;
- per inserire nelle proprie strategie anche l’eventuale “riscatto” di aree a standard, al termine del periodo decennale dei vincoli espropriativi.
L’arrivo della L.R. 20/2001 e l’idea di PUG
Nel frattempo, però, il contesto normativo cambia. Con la Legge Regionale Puglia n.20/2001 il legislatore regionale introduce un modello diverso di governo del territorio, lo strumento cardine non è più il PRG, ma il Piano Urbanistico Generale (PUG). Al centro vengono posti il tema della partecipazione pubblica, il ruolo delle osservazioni ex art.11, il riferimento ai principi della L.241/1990 sul giusto procedimento.
La logica è chiara; superare i piani meramente “espansivi” e zonizzati, orientando la pianificazione verso la riqualificazione dei tessuti esistenti; il contenimento del consumo di suolo; l’integrazione con i piani settoriali (paesaggio, rete ecologica, piano delle infrastrutture, attività estrattive, ecc…) e soprattutto la costruzione di un contraddittorio strutturato con i soggetti incisi dalle scelte di piano.
Per anni, però, a Martina Franca, come in molti altri Comuni pugliesi, il PRG del 1984 continua a vivere di varianti puntuali, accordi di programma, piani attuativi selettivi, delibere commissariali, reiterazioni di vincoli a standard approvate in sede regionale.
Nascono così; accordi di programma per insediamenti turistico–ricettivi in variante al PRG; provvedimenti di Commissari ad acta chiamati a ritipizzare aree colpite da vincoli scaduti; varianti generali alle NTA approvate dalla Regione, con reiterazione delle destinazioni a servizi (standard) su molte aree già “scadute” dal punto di vista espropriativo.
Il risultato è un quadro stratificato; un PRG nato negli anni ’80, ma continuamente ritoccato, dove aspettative edificatorie, vincoli a servizi, accordi convenzionali e giudicati amministrativi convivono in modo non sempre lineare.
L’avvio del percorso verso il PUG
Su questo sfondo, le Amministrazioni comunali succedutesi decidono di compiere il passo che la normativa regionale sollecita da tempo, abbandonare il vecchio PRG e dotarsi di un PUG coerente con la L.R. 20/2001, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nonché con il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Taranto.
Il percorso – come emerge dagli atti oggi oggetto di ricorso – passa attraverso alcune tappe significative:
- avvio del procedimento e definizione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), con il coinvolgimento di uffici interni e strutture esterne;
- ricorso, in una prima fase, a un incarico esterno di progettazione mediante procedura ad evidenza pubblica di rango europeo;
- a seguito di tale gara di evidenza europea, in data 18.09.2017 è stato stipulato il contratto d’appalto per la redazione del P.U.G. con un Raggruppamento Temporaneo di professionisti;
- tale contratto è stato risolto per inadempimento;
- successiva risoluzione del relativo contratto e scelta di internalizzare la redazione del PUG, affidandola al dirigente del settore competente e all’Ufficio di Piano interno;
- redazione del PUG mediante elaborazione degli elaborati strutturali (PUG_S) e programmatici (PUG_P), con definizione di (a) nuovi contesti urbani e rurali (CU, CR), (b) tessuti di completamento e di trasformazione (TC, TMI, TPM, AT, ATP), (c) ambiti per dotazioni (AD1, AD2) e (d) recepimento e dettaglio delle invarianti paesistiche e ambientali (aree boscate, reti ecologiche, aree a rischio idraulico).
Il percorso si concretizza, sul piano sostanziale, in due atti cardine:
- la Delibera di Consiglio comunale n.55 del 25 luglio 2024, con cui il PUG viene adottato;
- la Delibera n.65 del 29 luglio 2025, con cui il Consiglio esamina le osservazioni presentate e assume le determinazioni di accoglimento o diniego, sulla base delle schede di “Istruttoria dell’Ufficio” predisposte dal dirigente e dall’Ufficio di Piano.
È proprio su questa seconda delibera – e, “in parte qua”, sulle scelte del PUG da essa confermate – che si concentra oggi il contenzioso davanti al TAR Puglia – Lecce.
Sedici ricorsi distinti, tutti rivolti a contestare, da prospettive diverse, come il nuovo PUG ha letto il passato e ha scritto il futuro urbanistico della città.
Con la Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 25 luglio 2024, il Comune di Martina Franca adotta il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), in attuazione della L.R. Puglia n. 20/2001. Con la successiva Delibera n. 65 del 29 luglio 2025, il Consiglio esamina e definisce le osservazioni presentate da cittadini, imprese e operatori economici.
A valle di questo iter vengono proposti sedici distinti ricorsi al TAR Puglia – Lecce, tutti diretti contro il Comune di Martina Franca e tutti sottoscritti dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, in rappresentanza di cittadini proprietari e imprese produttive.
Le posizioni soggettive sono diversissime ma la struttura dei motivi di ricorso è omogenea.
In estrema sintesi, i profili comuni sono quattro:
- svuotamento della fase partecipativa e delle osservazioni ex art. 11 L.R. 20/2001;
- inadeguata considerazione del quadro fattuale e delle pregresse scelte pianificatorie;
- uso particolarmente gravoso di standard urbanistici, dotazioni e invarianti paesistiche su suolo privato;
- un motivo trasversale che investe l’assetto complessivo del PUG, ossia la figura del dirigente–progettista del PUG, che cumula ruoli centrali in tutte le fasi del procedimento.
Tutti i ricorsi muovono dal medesimo presupposto; la fase delle osservazioni al PUG non avrebbe rispettato il modello partecipativo disegnato dalla L.R. Puglia n. 20/2001 e dall’art. 9 della L. n.241/1990.
Ogni osservazione, infatti è stata presentata dopo l’adozione del PUG; è stata articolata in modo approfondito; è stata poi “riassunta” nelle schede interne di “Istruttoria dell’Ufficio” che accompagnano la delibera di consiglio comunale n.65/2025.
Ed è proprio qui che, secondo i ricorrenti, il sistema si incrina; infatti in moltissimi casi, la risposta del Comune si riduce a poche righe, con formule ricorrenti quali:
- “osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con l’impostazione generale della zonizzazione del PUG”;
- “osservazione non accoglibile in quanto le aree risultano già adeguatamente valorizzate”;
- “accoglimento non possibile poiché determinerebbe disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe”;
- “non accoglibile per contrasto con il dimensionamento complessivo del PUG”.
In altri termini, il Comune non spiega perché l’osservazione è sbagliata o inaccoglibile; si limita a ripetere che il PUG ha deciso diversamente. Ma questa non è motivazione, è un circolo vizioso.
L’art.11 L.R. 20/2001, letto in combinato con l’art.9 L. 241/1990, impone un vero contraddittorio, non la mera presa d’atto che “l’osservazione contrasta con il piano”; altrimenti la fase partecipativa diventa una liturgia vuota.
Si pubblica il PUG, si ricevono memorie articolate, ma la risposta è sostanzialmente …<<no, perché il PUG è questo>>.
È un’accusa circostanziata.
Non si contesta solo il contenuto delle scelte di piano, ma la lealtà del procedimento.
Il motivo più delicato e trasversale, tuttavia, è quello che riguarda la figura del dirigente comunale incaricato del PUG.
In pressoché tutti i ricorsi, tra gli ultimi motivi, si legge una contestazione di questo tenore: “Incompatibilità del tecnico incaricato nel procedimento di redazione, adozione e osservazione del P.U.G. e violazione dei principi di imparzialità e separazione delle funzioni amministrative”.
La sequenza ricostruita dagli atti è, in estrema sintesi, la seguente:
- Il Comune avvia una procedura europea per affidare all’esterno la redazione del PUG, con un raggruppamento di professionisti incaricato.
- Tale contratto viene successivamente risolto per inadempimento, con determinazione dirigenziale.
- La Giunta opta per l’internalizzazione della progettazione, affidando il PUG proprio al dirigente del settore competente, che assume il ruolo di:
- progettista del PUG e coordinatore dell’Ufficio di Piano;
- responsabile del procedimento (RUP) per la formazione del piano;
- responsabile VAS;
- estensore delle istruttorie tecniche sulle osservazioni e delle relative “proposte di determinazione”;
- firmatario dei pareri tecnici allegati alle delibere consiliari di adozione del PUG (D.C.C. n.55/2024) e di esame delle osservazioni (D.C.C. n.65/2025).
Di fatto, secondo la prospettazione dei ricorsi, il medesimo soggetto:
- elabora le scelte di piano;
- istruisce le osservazioni che criticano quelle stesse scelte;
- formula la proposta tecnica di accoglimento o diniego;
- esprime parere favorevole alle delibere che approvano il PUG e consolidano le controdeduzioni.
Questa situazione, viene riassunta dalla difesa, come corto circuito organizzativo, richiamando l’art. 97 Cost., che impone all’amministrazione un’azione improntata a imparzialità e buon andamento; gli artt. 6 e 7 della L. n.241/1990, sul dovere di astensione in caso di conflitto (anche solo funzionale) e sulla corretta gestione del procedimento e le norme di settore che, almeno in materia paesaggistica, richiedono una distinzione tra chi cura la pianificazione urbanistico–edilizia e chi esercita funzioni di tutela.
Non viene dedotto un conflitto d’interessi patrimoniale, bensì un tema di architettura delle funzioni:
- chi è autore delle scelte di piano non dovrebbe essere anche l’unico filtro tecnico che valuta e rigetta le osservazioni dei privati;
- la concentrazione di tutti i ruoli chiave in un solo dirigente riduce al minimo il controllo interno e il confronto dialettico, trasformando la fase delle osservazioni in una sorta di “autoverifica” del progettista.
In alcune memorie nell’ambito del processo di partecipazione attivato dall’ottobre 2021 in poi, si ricordano anche le perplessità espresse, in fase precedente, da alcuni Ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Forestali, Geologogi e Periti Agrari) e dall’INU Puglia, che avevano sollevato dubbi sulla contemporaneità dei ruoli ricoperti dal medesimo dirigente nel procedimento PUG.
Se questo motivo dovesse essere ritenuto fondato, l’effetto – almeno in astratto – potrebbe andare ben oltre i singoli lotti, potrebbe mettere in discussione la legittimità complessiva dell’iter di formazione del PUG, quantomeno nella parte in cui si è tradotto in un blocco “monolitico” delle osservazioni.
Un contenzioso che interroga il modello di pianificazione
L’impugnativa del (definendo) PUG di Martina Franca non si limita a chiedere più volumetria o migliori indici fondiari.
Nello schema dei motivi comuni – così come formulati dagli avvocati Pellegrini e Millefiori – c’è una critica molto più ampia:
- al modo in cui è stata gestita la partecipazione,
- al modo in cui sono stati letti e ponderati i pregressi urbanistici e i giudicati,
- al modo in cui standard e invarianti sono stati calati sulle proprietà,
- (e soprattutto) al modo in cui è stata organizzata la funzione tecnica interna, concentrando in un solo dirigente il ruolo di progettista, istruttore e “giudice” delle osservazioni.
Adesso la parola passa al TAR Puglia – Lecce, chiamato a misurare la tenuta di queste censure e a dire se, e quanto, esse possano incidere sulla sopravvivenza dell’attuale impianto del PUG martinese.
Ma il punto vero va oltre i confini di Martina Franca. Questa vicenda porta in superficie una domanda che riguarda molti enti locali; è davvero compatibile con i principi di imparzialità, partecipazione e trasparenza un modello di pianificazione in cui il medesimo ufficio – e talvolta la stessa persona fisica – disegna il piano, filtra e respinge le osservazioni e, in definitiva, certifica la bontà delle proprie scelte? Dalla risposta che arriverà da questo contenzioso potrebbe dipendere non solo il destino del PUG di Martina Franca, ma anche il modo in cui, d’ora in avanti, i Comuni pugliesi saranno costretti a ripensare l’architettura interna degli uffici tecnici quando si decide la partita più delicata … quella sul governo del territorio.
… continua.
Amministrativo | Urbanistica / Edilizia